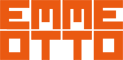
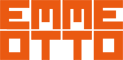
CORRADO CAGLI, TRA SPERIMENTAZIONE E PIACERE DELL’IMMAGINE
in collaborazione con Bertolami Fine Art
Opening sabato 29 marzo 2025 | ore 17.00 – 20.00
EMMEOTTO ARTE | ROMA
Via di San Pantaleo, 66 – 00186
fino al 30 maggio 2025
“[Intervistatore]: Lei passa per un artista difficile e intellettuale.
Cagli: Non so cosa voglia dire. Piero della Francesca non era intellettuale? Tutti i grandi pittori non sono stati intellettuali? Non lo era forse Michelangelo? E per non nominare Leonardo da Vinci. E Picasso, e Max Ernst non sono intellettuali?
[Intervistatore]: I collezionisti che vogliono speculare sulle sue opere non sanno come classificarle.
Cagli: Può darsi. E mi auguro di riuscire a evitare sempre le etichette. Non mi sento farfalla da entomologhi.”
Da «L’Europeo», anno XXI, n. 7, 14 febbraio 1965.
Corrado Cagli ha attraversato il Novecento avventurandosi tra le più varie correnti. Dalle seduzioni déco della ceramica – la manifattura Rometti – diretta in gioventù, al muralismo degli anni ’30, all’espressionismo intimista del postbellico; le sperimentazioni lo hanno condotto ad un’arte cerebrale, e al recupero dei linguaggi primitivi dell’Africa e dell’Australia. Egli riuscì ad essere molteplice senza dimenticare la pittura figurativa e il disegno, praticato con la perizia di un artista antico. Lorenza Trucchi ne ha tracciato un ritratto, come sempre, sintetico ed efficace: “Cagli resta […] un caso a parte, unico ed inclassificabile, nel panorama della nostra pittura […]. Certo, la sua versatilità creativa lo ha fatto, talora, scambiare per un seguace di formule e di forme […]. Ora è indubbio che Cagli, come un pittore del nostro Rinascimento, sapesse restare fedele al culto del disegno (fu senza dubbio uno dei nostri maggiori disegnatori), al fare sapiente, all’inesausta ricerca dello stile; tuttavia, sotto questa pelle di artigiano sublime, talvolta perfino di culto manierista, ribolliva un salutare spirito ribelle, una dionisiaca commistione di istinti e umori” (da L. Trucchi, Adesso l’arte è molto più povera, in «Momento sera», Roma, 29 marzo 1979).
Come acutamente notato da Fabio Benzi, Cagli coltivò una ricerca in fondo sempre unitaria, che oggi lo avvicinerebbe ai postmoderni, incuranti di polemiche e formalismi. Il metodo con cui l’artista lavora si consolida all’indomani dell’esilio americano, avvenuto a seguito della promulgazione delle leggi razziali in Italia nel 1938. La crisi della spinta propulsiva e mitopoietica che l’artista aveva ravvisato nelle imprese culturali dell’Italia fascista non riesce a scalfire la spinta nel prendere posizione e partecipare al dibattito delle idee. Questo “essere nel mondo” lo portò a partecipare – divenuto ormai cittadino americano – alla guerra mondiale, portandolo a partecipare ai grandi eventi storici di quell’epoca come lo sbarco in Normandia e la liberazione del campo di sterminio di Buchenwald. Forse prendendo a modello l’atteggiamento di Picasso – ed estremizzandone ancor più le conseguenze – Cagli ha contaminato da quel momento le sue ricerche in una totale libertà.
In ordine cronologico la prima opera qui esposta è un disegno del 1940 che raffigura un Atleta: ci racconta un artista memore delle ricerche del periodo giovanile, dell’epoca dell’École de Rome. Il tratto è pulito, preciso. La figura solenne dell’Atleta è spogliata da ogni marziale retorica. L’uomo è proposto nella sua corporea natura umana, offre le terga allo sguardo dell’osservatore.
Da questa opera siamo proiettati in un mondo totalmente differente: nel magma delle ricerche de dopoguerra, appena dopo la parentesi neosurrealista intorno al 1947. Un nuovo Cagli che aveva scatenato le polemiche dei giovani artisti del gruppo Forma Uno: lo accusavano di essere un revenant dell’epoca fascista, la sua nuova arte liquidata come importazione delle tendenze americane neoromantiche.
Risale a quegli anni l’interesse per i tarocchi che l’artista coltivò in parallelo all’amicizia con il poeta Charles Olson e che lo portò ad avvicinarsi al mondo delle geometrie non euclidee. Magia, matematica, procedimenti surrealisti, avvicinamento all’arte africana primitiva. Ecco le matrici delle opere esposte in questa mostra. Le tecniche sono le più sperimentali: dal frottage sulla paglia di Vienna o su trame grosse di tessuti, al grattage, agli spruzzi di aerografo, come in Attesa (1950), Gebel il Gac (1950), o in Kandarali sound (1950), morbidi cerchi associati alle melodie dell’antica civiltà afghana, od anche in Kalamara (1950).
Parafrasi di Gog del 1950 rievoca attraverso il mito biblico la cecità del caos, lo scontro delle masse anonime nel conflitto mondiale. Il mondo umbratile e primordiale dei morti è evocato nella Discesa nello Sceol (1954) in cui la scena è costruita attraverso figure sedimentate e giustapposte come totem africani. Ancora un totem e iscrizioni in lingue sconosciute appaiono in Signori a Sumen (1954), nel quale il titolo rievoca la grande decadenza dell’antica città turca di Bulgaria. Storie lontane e disperse, riferimenti intellettuali mai casuali, una profondità speculativa raggiunta con apparente semplicità di mezzi rendono non semplice la comprensione di questo artista ancor oggi. Attraverso le sue ricerche pare leggere in controluce il destino di altri artisti venuti dopo di lui: per esempio gli alfabeti fantastici di Luigi Serafini. Spesso sono i titoli delle opere a guidare chi osserva nella decodificazione del tema rappresentato, come per l’art concettuale.
L’Aleph (1954): rappresentazione anch’essa totemica e geometrizzante della figura del bagatto, un mito sul quale Cagli torna ossessivamente in più e più occasioni, a partire dalla corrispondenza con Olsen; un arcano che raffigura in traslato l’artista, nell’autoritratto in veste di mitico creatore.
In un altro gruppo di opere predomina invece la ricerca sulla geometria non euclidea, deprivata anche del piacere del racconto, tramutata in puro segno esoterico. Opere come Per Erasmo (1964), Capo Tribù (1964); altre ancora, infine, in cui il referente figurativo scompare del tutto: Reti pareti alcantara (1967), A Rirì (1968), Arcano n.9 (1968), Gremlin (1968), Variazione ogivale (1969), fino a Catafratto (1975). L’artista è ora consapevole come un demiurgo dell’esattezza e dell’importanza del suo segno: gli basta questo per creare l’epifania dell’opera.
Due grafiche dell’ultimo periodo dell’artista propongono una nuova metamorfosi: Variazioni cromatiche intorno a un centro (1974) e Narciso (1976), sono opere nelle quali Cagli riprende i filoni di ricerca astratto e figurativo e li rilegge con il colore e un nuovo gusto per la pop art.
Andrea Iezzi